Sette condanne in primo grado, e in appello sei assoluzioni e una condanna. Il processo alla “Commissione Grandi Rischi” del terremoto dell’Aquila 2009 resta ancora oggi un caso emblematico per riflettere sulle connessioni (e i cortocircuiti) esistenti tra le emergenze, la comunicazione e il mondo delle leggi.
Un territorio finora poco esplorato con un simile approccio trasversale e multidisciplinare è quello su cui si affaccia il lettore di “Terremoti, comunicazione e diritto”, raccolta di saggi appena pubblicata da FrancoAngeli (il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “180 Amici L’Aquila”) che si pone l’obiettivo di riflettere sul processo alla commissione di esperti che il 31 marzo del 2009 fu chiamata a supportare i decisori di fronte al bisogno di informazione della popolazione abruzzese, messa in allarme da tre mesi di piccole scosse: quello sciame sismico che una settimana più tardi sarebbe virato nel terremoto di magnitudo 6.3 che distrusse L’Aquila e uccise 309 persone.
CURATORI AMATO, GALADINI E CERASE
A curarne i contenuti (una serie di saggi firmati da autorevoli scienziati, ricercatori, sociologi, comunicatori, giuristi ed esperti di terremoti) il sismologo Alessandro Amato, dirigente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il geologo Fabrizio Galadini, responsabile della sede dell’Aquila di Ingv e il sociologo Andrea Cerase, esperto in comunicazione del rischio. Nella facoltà di Sociologia della “Sapienza” di Roma lo scorso 17 giugno molti degli autori e alcuni ospiti, dal direttore del Coris – Diparimento Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Mario Morcellini a Marco Cattaneo, giornalista e direttore de “Le Scienze”; dal professore di metodologia della ricerca sociale Leonardo Cannavò al presidente di Ingv Stefano Gresta e a Marco Magheri, vice segretario generale della Associazione italiana comunicazione pubblica.
La presentazione del libro è stata l’occasione per un confronto dal vivo su temi “caldi” come il rapporto tra scienza e informazione, scienza e diritto, scienza e istituzioni pubbliche. Gettando lo sguardo ciascuno nel campo altrui, scienziati, comunicatori e giuristi hanno potuto constatare attraverso il filtro della controversa vicenda aquilana i limiti incontrati dalle proprie discipline di fronte alla tematica dei terremoti, in cui (più che altrove) regna l’incertezza e la non prevedibiltà e dove la mancanza di alcuni dati e l’impossibilità di previsioni affidabili mettono in crisi le consuete categorie, i parametri, i valori su cui generalmente si basano i giudizi e le decisioni che regolano la vita associata.
Questa non prevedibilità – hanno spiegato i curatori e gli autori dei saggi in sala – rimette in discussione gli elementi a disposizione per valutare i problemi e apre una questione di comunicazione, legata al linguaggio (notevole, ad esempio, la differenza tra “prediction”, “forecasting” e “prevision”) con cui si dovrebbe fornire la giusta percezione del rischio e si dà vita alle azioni di prevenzione; c’è inoltre un problema di categorie del diritto che impattano con le valutazioni di avvocati e giudici (vedi ad esempio, l’uso fatto del principio di precauzione).
CATEGORIE SUPERATE
In simili condizioni di complessità e interconnessione tra ambiti così diversi non è più sufficiente – spiegano i curatori del volume – fornire rassicurazioni alla popolazione o assumere decisioni politiche che (nelle intenzioni di chi le prende) dovrebbero mettere tutti d’accordo. Ci si confronta con la mancanza di un linguaggio comune (tra politici, scienziati in possesso di dati e informazioni e giornalisti chiamati a comunicare efficacemente); e anche i magistrati di fronte a situazioni come quella della “grandi rischi” si sono ritrovati a giudicare secondo principi e ipotesi di reato che risultano talvolta insufficienti o inadeguati in contesti del genere.
Si pongono quindi nuove sfide relative alla gestione e alla comunicazione del rischio per chi voglia porsi con l’obiettivo concreto di realizzare una maggiore resilienza dei territori di fronte a eventi complessi e potenzialmente catastrofici come i terremoti, evitando la diffusione di messaggi contraddittori e equivoci. Da un lato – affermano i relatori – è necessario prendere coscienza della dimensione non prevedibile di certi fenomeni. Questo eviterebbe in partenza la pretesa di risposte che la scienza dei disastri non è ancora in grado di fornire, smettendo di alimentare il falso mito che la vede ancora (talvolta) dispensatrice di certezze. Dall’altro sono state ricordate le carenze ancora oggi presenti nella informazione scientifica italiana (per non parlare del giornalismo di cronaca, affamato di notizie e a digiuno di cultura scientifica) auspicando un diverso approccio alla comunicazione di rischi ed emergenze sia in tempo di pace, sia in tempo di crisi. Con un’informazione ancora lontana dalle persone su tematiche come malattie e stili di vita ma con tre quotidiani sportivi in edicola, non stupisce – ricorda uno dei relatori – il successo (come nel caso dell’Aquila) di personaggi locali che hanno fatto previsioni sui terremoti a titolo personale, considerati alla stregua di veri scienziati.
RITARDO CULTURALE
In aula si è discusso poi del ritardo culturale italiano e di una vera e propria “mancanza di alfabetizzazione” sul rischio sismico di cui soffrirebbe il nostro Paese nonostante la nota forte sismicità del territorio nazionale, le conoscenze avanzate sui fenomeni naturali e le leggi all’avanguardia di cui disponiamo. Una scarsa cultura dei rischi, diffusa a livello delle grandi città come nei piccoli centri, che non è riscontrabile in paesi sismici economicamente avanzati come il Giappone, gli Usa o altri che si affacciano sul Pacifico. Un deficit culturale che vede i temi della prevenzione sostanzialmente assenti dai programmi politici e dalle campagne elettorali, così come (almeno finora) lontani dalle richieste dei cittadini ai propri candidati.
In uno scenario del genere, in cui si resta spesso ancorati a schemi e ruoli vecchi, la sola prospettiva da intraprendere per progredire e non tornare a vivere tragedie come quelle dell’Aquila o episodi come quello delle sentenze “Grandi Rischi” – hanno spiegato alcuni relatori in aula – potrebbe essere quella di arrivare a una “gestione partecipata dei rischi” in grado di abbattere i recinti tra le diverse discipline, partendo ciascuno da una assunzione di responsabilità, riscoprendo la forza di un approccio interdisciplinare alla valutazione, gestione e comunicazione dei rischi; evitando l’autoreferenzialità più volte rimproverata a tecnici e scienziati che possiedono e maneggiano le informazioni preziose contenute nei dati; accrescendo la rilevanza degli addetti stampa nelle organizzazioni e la professionalità dei giornalisti. Restituendo il giusto peso alle scienze e diffondendo la conoscenza scientifica tra la popolazione, dando più valore alla prevenzione rispetto alla emergenza, ricreando infine un legame forte tra cittadini più attenti e istituzioni più autorevoli.
LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
E soprattutto superando quella visione della comunicazione come elemento residuale dei processi decisionali, utile solo a orientare il consenso, rispettare doveri burocratici o a scaricare eventuali responsabilità “scomode”. Una buona comunicazione che può costruire una nuova cultura del rischio in quanto già valore portante della nostra comunità. Ma la comunicazione saprà essere efficace quanto più si rafforzerà nei cittadini la fiducia che oggi sembrano aver perso nei confronti di istituzioni, scienziati e giornalisti.
Francesco Unali
(Pubblicato su “La Protezione civile italiana” n. 6 – luglio-agosto 2015)
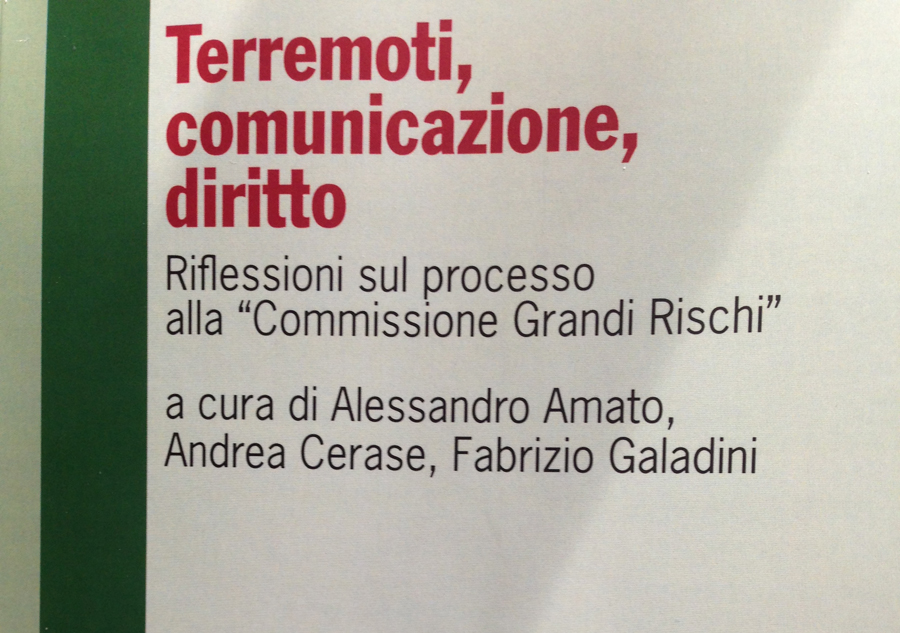
COMMENTS